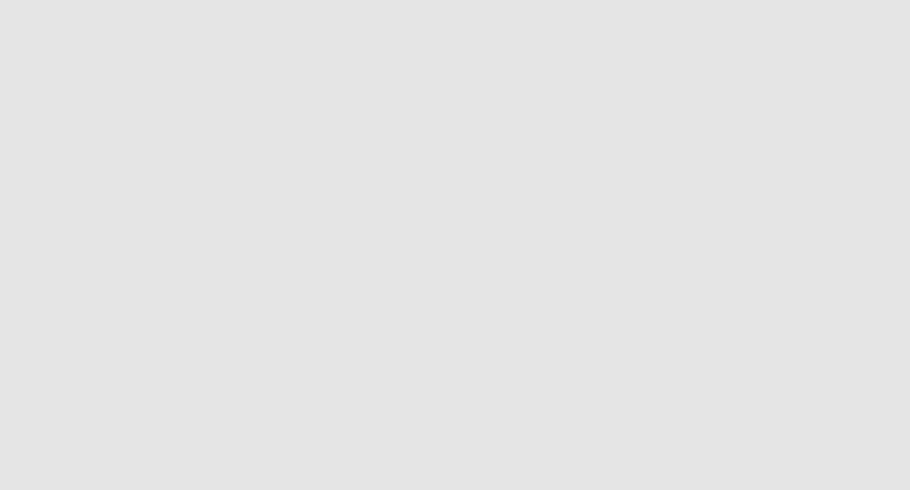Catania Antica
Fervida realtà urbana e crocevia di culture, la colonia Katane venne fondata nel 729 a.C dai greci calcidesi guidati da Tucle che cacciarono i siculi per insediarsi in quell’angolo dell’isola. Dopo la conquista della città, da parte del tiranno di Siracusa Gerone I nel 476 a.C., Catania prese il nome di Aitna ma è solo tempo dopo, con Ducezio, che si riappropriò dell’appellativo originario. Un’eredità, quella greca, di cui la città risente ancora oggi e che traccia insieme alla dominazione romana un selciato profondo. Fulgidi esempi risalenti all’età imperiale sono l’anfiteatro, il teatro, l’odeon, i complessi termali e il sistema di approvvigionamento idrico.
Luoghi da immortalare
- Terme Achilliane
- Pozzo Gammazita
- Terme dell'Indirizzo
- Terme di Sant’Antonio
- Foro Romano
- Teatro Romano e Odeon
- Terme della Rotonda
- Terme romane di Piazza Dante
- Anfiteatro Romano
Il tuo giro avrà inizio nei sotterranei del Museo Diocesano dove sono custodite le Terme Achilliane, uno degli edifici più importanti dell’età imperiale. Costruite nel IV-V secolo d.C., fu solo dopo il terremoto del 1693 che Ignazio Paternò Castello le riportò alla luce. Quando l’architetto e incisore francese Jean-Pierre Houёl arrivò a Catania, in occasione del suo Grand Tour, rimase talmente colpito, del vasto complesso da riprodurlo in alcuni gouaches custoditi all’Hermitage di San Pietroburgo mentre nel XIX secolo Adolf Holm descrisse parti dell’edificio, scoperte nel 1856 sotto il Seminario dei Chierici e in Via Garibaldi, nell’opera “Catania Antica”. Oggi solo una parte delle terme è visitabile, si tratta di un'ampia camera con soffitto a crociere, al centro della quale si trova una vasca originariamente rivestita in marmo e probabilmente utilizzata per i bagni di fango mentre le acque del fiume Amenano scorrevano attraverso un corridoio situato nella parte occidentale dell’edificio.
Imbocca ora il mercato della Pescheria per raggiungere via San Calogero e visitare il pozzo di Gammazita, dove realtà e leggenda si mescolano. Il nome, con molta probabilità trae origine dalla parola araba “al gawsit”, che indica luogo dell'acqua dolce tuttavia la narrazione popolare muove dalla vicenda della bellissima Gammazita, la quale per sfuggire alla brutale violenza di un soldato francese invaghito di lei, decise di lanciarsi nella sorgente. Altre versioni legano la vicenda alla vendetta d’amore di donna Macalda Scaletta e alle sue sordide trame per far sedurre la ragazza dal cavaliere De Saint Victor. Nel panegirico di don Giacomo Gravina si fa invece riferimento alla ninfa Gemma, “zita” (fidanzata) con il pastore Amenano, che Proserpina trasformò in fonte per allontanarla dalle attenzioni di Plutone, secondo altre fonti, infine, il toponimo muove dalle lettere dell’alfabeto, gamma e zeta, incise su uno dei muri del pozzo. La fonte, sepolta sotto 14 metri di lava dall’eruzione del 1669 venne riportata alla luce già nel Settecento per l'approvvigionamento idrico dell’area oltre a essere raccontata da molti pittori durante il loro Grand Tour. L’accesso al pozzo, ancora oggi, avviene attraverso la scalinata originale adagiata sulle cinquecentesche mura della città tinteggiate di un rosso ferroso, proprio come il sangue di Gammazita.
Prosegui il tuo percorso verso piazza Currò dove troverai le Terme dell'Indirizzo, le quali prendono il nome dall’omonima Convento carmelitano di Santa Maria dell’Indirizzo. Un nome legato a Don Pedro Téllez-Girón, duca di Osuna e Viceré di Sicilia e Napoli, che nel 1610 si salvò dal mare in tempesta grazie a una luce che lo indirizzò verso un approdo sicuro. Si tratta del complesso termale meglio conservato d’Europa risalente alla tarda età imperiale, databile fra il III e il V secolo d.C. Dell’edificio - opera cementizia con blocchi in pietra lavica - sopravvivono l’Apodyterium, un ambiente rettangolare adibito a spogliatoio e il Frigidarium. La struttura è dotata inoltre di un Tepidarium a pianta trapezoidale da cui si poteva accedere alle tre vasche del Calidarium, una stanza a pianta ottagonale dedicata ai bagni a vapore dalla quale è possibile osservare le suspensurae a sorreggere la pavimentazione e chiusa da una cupola che arriva ai 10 metri di altezza e infine di un Laconicum, destinato al bagno di sudore.
Nel quartiere di San Cristoforo, troverai le Terme di Sant’Antonio,poi, un piccolo impianto termale conosciuto anche come Bagni Sapuppo, dal nome del raggruppamento di case di proprietà della prestigiosa famiglia presente a Catania sin dalla fine del Cinquecento. Si tratta di un pozzo e di un Balneum privato coevo certamente parte di un edificio di epoca romana, rinvenuto dal principe di Biscari nell’ultimo trentennio del XVIII secolo. Con molta probabilità è datato I secolo d.C., e il bagno usava le acque del fiume Amenano per alimentare il Frigidarium. Tra gli ambienti c’è un vano quadrato con otto sedili e quattro scale ma anche nicchie, lesene, pilastri e colonne, i pavimenti poi sono riccamente decorati con marmi, affreschi e stucchi policromi sebbene negli anni Novanta gli scavi siano stati ricoperti da una struttura di metallo e vetro, in modo da proteggerli. La parte scoperta dello scavo consente di vedere come le stanze fossero comunicanti tra loro e come si trattasse di bagni freddi o con molta probabilità che le stanze si riempissero d’acqua per arrivare fino a livello della Porta in modo che, utilizzando i tanti sedili incassati, ci si potesse lavare comodamente.
A questo punto prosegui su via Garibaldi, da qui raggiungi rapidamente via Orfanelli alla volta di quello che a lungo è stato considerato il Foro Romano, una serie di diversi edifici circondati da un'ampia area centrale riportati alla luce nel 1903. Le fonti storiche, come Lorenzo Bolano nel Cinquecento, descrivono la presenza di otto ambienti con copertura a volta a sud e altri quattro a nord, molti dei quali sono andati perduti a causa dello sviluppo urbano. Una tesi, questa, sconfessata nel 2008 dall’archeologo Edoardo Tortorici, che la collegò piuttosto agli horrea, i magazzini dell’annonario del quale rimangono soltanto un paio di ambienti attigui visibili a sud, con ingresso architravato sormontato da un'apertura ad arco molto simile nell'aspetto ai magazzini del Foro Traianeo, oltre alle aperture ad arco. I resti visibili del foro offrono ancora oggi uno spaccato della vita quotidiana dell'antichità e sono parte integrante del patrimonio storico di Catania.
Dirigiti adesso in via Sant’Agostino per raggiungere in breve uno dei complessi archeologici più grandi di Catania: il Teatro Romano e l'Odeon, che coprono una superficie di circa 6.400 mq, disposti tra le vie Vittorio Emanuele, Crociferi e Teatro greco sede un tempo dell’acropoli. Sebbene la struttura risalga al I secolo d.C. fu nel secolo successivo che cavea, edificio scenico e ingresso furono ampliati tanto che il teatro, che conserva ancora tratti di epoca greca, raggiunse una capienza di circa 7.000 spettatori. Nella parte ovest del sito si trova invece l’Odeon datato II secolo d.C., dalle dimensioni nettamente più ridotte, poteva accogliere fino a 1.500 spettatori. Il prospetto esterno, impreziosito dalla bicromia della pietra lavica e del laterizio, si snoda quindi in una successione di arcate. La struttura destinata a spettacoli, gare poetiche e canore finì in stato di abbandono tra il VI e il VII secolo d.C.,in particolare nel XV secolo molti dei materiali di rivestimento furono impiegati per la costruzione di altri edifici e con il tempo anch’esso fu inglobato tra le mura dei palazzi cittadini che si facevano sempre più numerosi.
Situate vicino al Teatro Romano, le Terme della Rotonda costituiscono un’importante struttura termale che come riportato negli scritti del principe Biscari comprendeva anche le terme di Piazza Dante. Edificate tra il I e II secolo d.C e attive fino al VI secolo d.C.,in epoca bizantina videro sorgere sui suoi ruderi la Chiesa di Santa Maria della Rotonda con l’imponente cupola a tutto sesto circondata da contrafforti e posta su un edificio a perimetro quadrato all'interno del quale è ricavata un'aula circolare. La Chiesa fu a lungo ritenuta il più antico tempio cristiano di Catania, probabilmente consacrato alla Madonna nel 44 d.C..Durante i bombardamenti aerei del 1943 venne danneggiata, ecco perchè nel decennio successivo furono effettuati lavori di consolidamento affidati all’archeologo Guido Libertini. La struttura termale è dotata di una sala absidata in direzione nord-sud probabilmente un frigidarium, un tepidarium a sud, un grande ambiente a est identificato in un calidarium mentre a ovest alcune tombe di epoca medievale e a completamento un pavimento in mosaico e impianti di riscaldamento a ipocausto.
Di fronte al Monastero dei Benedettini sono custoditi i resti di un edificio termale di età romana che testimonia la ricchezza di quest’area, all’interno della quale sono stati ritrovati diversi reperti archeologici, mosaici e resti significativi di costruzioni antiche rivestite di marmi e raffinate decorazioni. E’ probabile che si trattasse di una domus dal momento che la collina di Montevergine in epoca romana era un’area riservata ai cittadini più facoltosi. Sebbene non si conosca l’estensione della zona è probabile che si trattasse di una casa con più stanze che affacciavano su un cortile centrale con un portico colonnato. Lungo il lato occidentale vi sono alcune stanze quadrate, le tre verso nord sono ben conservate mentre le altre due stanze poste a sud vi fossero almeno altre due stanze delle quali rimangono pochi muri. Al centro dell’area si trova il Balneum un piccolo impianto termale privato dotato di un Tepidarium, Calidarium e Laconicum. A sud del balneum si trova una piccola costruzione circolare isolata mentre a nord un piccolo edificio rettangolare per una vasca, entrambe al servizio del balneum.
Via Santa Filomena ti porterà a Piazza Stesicoro, dove potrai ammirare i resti imponenti dell'Anfiteatro Romano definito dagli abitanti del posto come “Catania vecchia”. Costruito intorno al II d.C. e ampliato nel secolo successivo, era uno dei più grandi di Sicilia in grado di ospitare fino a 15.000 spettatori seduti e quasi il doppio in piedi. Oggi, solo una parte dell'originario edificio a forma ellittica è visibile mentre già nel V secolo sotto Teodorico così come nell’XI secolo con Ruggero II molti dei rivestimenti in marmo che ricoprivano la struttura in pietra lavica, furono saccheggiati per la costruzione di altri edifici tra cui la Cattedrale di Sant’Agata. Camminando fra i suoi corridoi potrai apprezzare la grandiosità e la solidità dell’architettura romana.